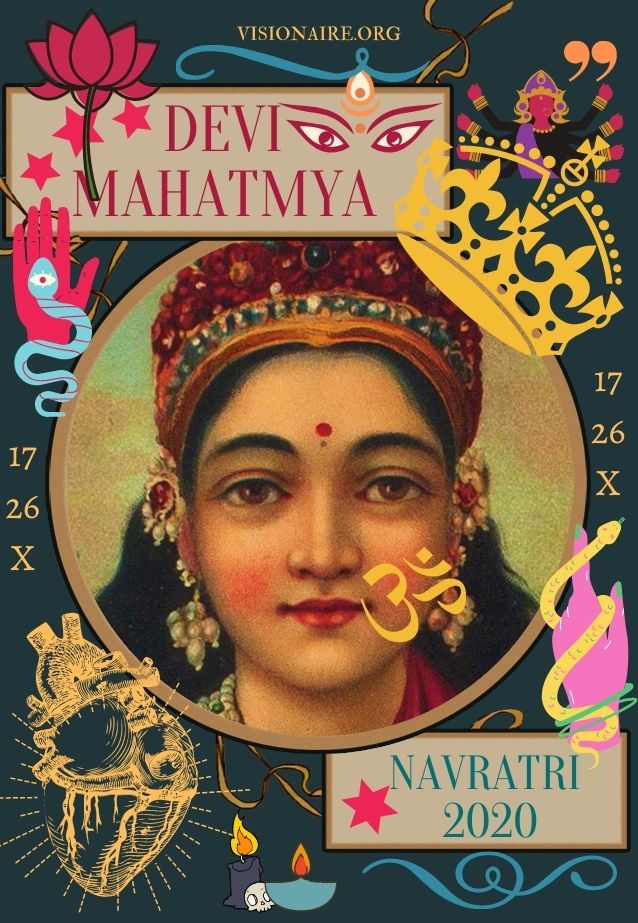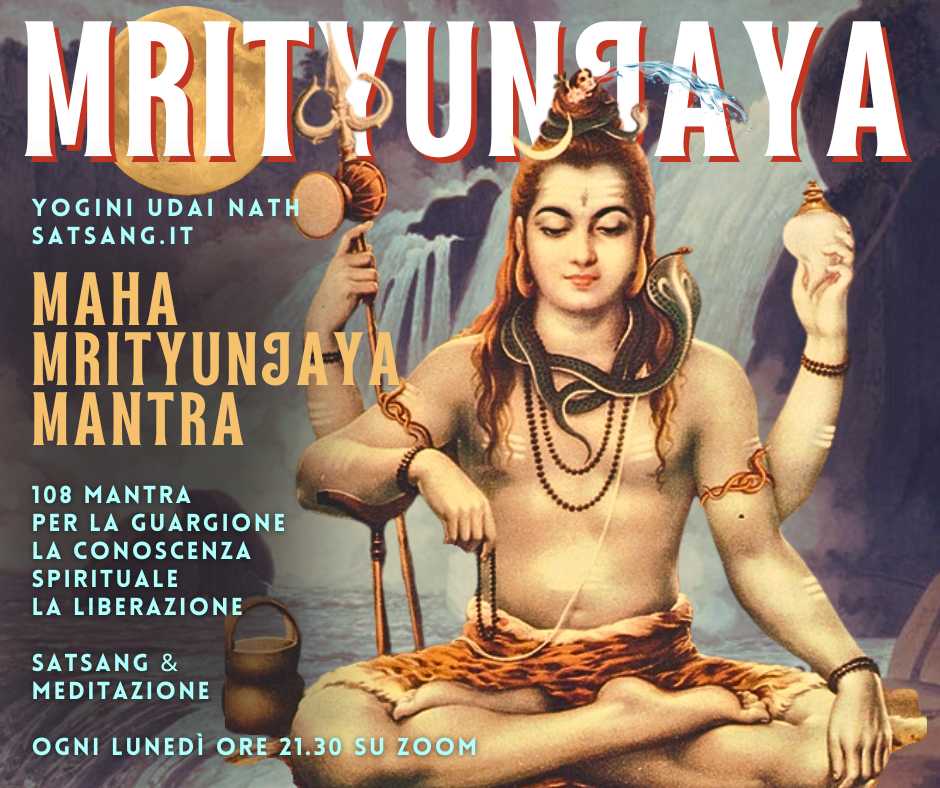IL RE, IL MERCANTE E IL SAGGIO
Il Devīmāhātmya inizia con il racconto del rishi Mārkaṇḍeya che narra di un re virtuoso, di nome Suratha, di come soffrisse per aver perduto il suo regno e come cavalcando da solo nella foresta fosse giunto all’eremo di Medha, un sant’uomo. Il racconto poi prosegue con l’arrivo all’eremo di un mercante di nome Samadhi, espropriato della sua ricchezza e scacciato dalla sua avida famiglia. In quel luogo, circondati dalla pace e dalla bellezza, entrambi si aspettano di trovare la tranquillità, ma al suo posto emerge un profondo tumulto interiore, alimentato da pensieri ricorrenti di smarrimento, tradimento e di attaccamento a ciò che si erano lasciati alle spalle. Il re riteneva che in quanto uomini di conoscenza, avrebbero dovuto saper individuare la causa della loro infelicità. Insieme si rivolgono a Medha, che immediatamente riconosce nella conoscenza intesa dal re la conoscenza del mondo materiale e non la comprensione approfondita della vera natura delle cose. Il compito del saggio sarà quindi quello di risvegliare i suoi due discepoli alla conoscenza spirituale più elevata. Medha rivela a Suratha e Samadhi che, come tutti gli esseri umani, anche loro sono vittima dell’inganno di Mahāmāyā, colei che getta persino il sapiente nell’oscuro vortice dell’attaccamento. Dopo aver soggiogato le loro menti, ella li lega al ciclo di esistenze transitorie (samsāra) e alle sofferenze che ne conseguono. Medha spiega ai discepoli che nulla in questo mondo è come appare. Il mondo è percepito attraverso i sensi, che sono sempre illusori. Esseri umani e animali sono ugualmente in grado di vedere, ascoltare, odorare, gustare e toccare, ma queste facoltà si sviluppano diversamente in base alla specie di appartenenza. Parlare di conoscenza sensibile del mondo vuol dire descrivere solo una delle tante esperienze possibili e poiché si fa esperienza diversa del mondo a seconda delle diverse capacità sensoriali di ogni persona, non esiste un unico mondo empirico uguale per tutti gli esseri viventi. Inoltre, la conoscenza ottenuta attraverso i sensi, condizionata dalla proprietà fisiche del tempo e dello spazio, non riguarda le cose come esse sono realmente ma come esse appaiono in relazione alle altre. Se un semplice atto di percezione sensoriale, che non differisce in complessità tra uomo ed animale, può essere così ingannevole, quali inganni è probabile trovarvi in comportamenti più complessi? Medha osserva che gli uccelli nutrono i propri piccoli anche quando afflitti dai morsi della fame, mentre gli esseri umani crescono i figli con l’aspettativa di ricompense future. Gli uccelli agiscono per istinto secondo uno schema predeterminato. Gli uomini oltre all’istinto posseggono capacità di ragionamento e di scelta, ma tali scelte sono spesso guidate da interessi, desideri e aspettative personali. Il Devīmāhāthya classifica sia la conoscenza istintiva che razionale come forme inferiori di conoscenza perché nessuna delle due può concedere la liberazione. Le creature viventi sono legate all’eterno ciclo di nascita morte e rinascita. Medha racconta che Mahåmāyā creò l’universo e che “afferrò le menti, anche quelle dei più saggi, e le trasse in inganno’ (DM 1:55). Ma, aggiunge, ella è anche “la conoscenza suprema, la causa di liberazione finale ed eterna” (DM 1:58). L’illusione di cui Medha parla è una questione meramente biologica. La parola sanscrita “moha” è tradotta variamente con “illusione, smarrimento, distrazione, infatuazione, errore, follia” ma nessuna di queste è in grado di rendere pienamente il senso di un modello globale di pensiero che non riconosce che le cose non sono come sembrano e accetta invece l’apparenza come realtà. Il vero significato di “moha” è perdita di consapevolezza ed è la causa di māyā, altra parola che nella lingua inglese non ha equivalenti. Inizialmente māyā indicava tutto ciò che è straordinario, i poteri sovrannaturali, la magia e la stregoneria, e più tardi, qualunque cosa avesse una connotazione negativa di inganno e di insidia. Nelle ultime Upaniśad, nel Sāmkhya e nelle filosofie del Vedanta, māyā assume una dimensione metafisica. La manifestazione di māyā nel Devîmāhātmya è più vicina a quella delle ultime Upaniśad, dove appare come divino potere di auto-occultamento. Ciò che nasconde è l’infinita consapevolezza che è Brahman. Ora, la definizione di moha come consapevolezza perduta inizia ad avere un senso.
La Śvetāśvataropaniśad equipara māya a prakṛti quale energia femminile attraverso la quale Śiva, il Signore di Māyā, crea l’universo (SV 4.9.10). Questo ritratto della controparte femminile di Śiva implica la personificazione di māyā come dea, e come tale la si incontrerà nel Devîmāhātmya. Il suo nome, Mahamāyā significa “la grande Māyā” oppure “colei la cui māyā è grande”. In entrambi i casi il suo nome implica un immenso potere.
Il re vuole saperne di più della Dea Mahāmåyā e Medha gli risponde raccontando la prima delle tre storie. Esistono tre storie perché ogni cosa nel mondo ha un principio, uno sviluppo e una fine, e su questo ciclo vitale la Devî presiede quale Creatrice, Conservatrice e Distruttrice universale. Nel primo episodio (carita) Ella appare nel suo aspetto cosmogonico di creatrice del mondo.
MAHĀMĀYĀ
Molto prima delle presente creazione, quando il precedente universo fu dissolto in un primordiale e infinito oceano, il beato Signore Viṣṇu giaceva in un profondo sonno meditativo. Ad un tratto dal cerume dell’orecchio di Visnu fuoriuscirono due demoni chiamati Madhu e Kaitabha con l’intento di uccidere Brahma, seduto sul loto germogliato dall’ombelico di Visnu. Disperato, Brahma provò di svegliare Visnu, ma invano, poiché il sonno che si era posato sugli occhi di Visnu era la dea Mahāmāyā stessa. Brahma allora ne cantò le lodi in un inno e le chiese di liberare Visnu dal suo incantesimo. Svegliatosi, Visnu vide i terribili Madhu e Kaitabha e ingaggiò con loro un combattimento lungo cinquemila anni fino a quando Mahāmāyā non intervenne confondendoli per mezzo dell’orgoglio. Avendo resistito fino ad allora alla forza di Visnu stesso, nella loro arroganza decisero di concedergli un desiderio ma compresero la loro follia troppo tardi perché quello che Visnu chiese fu di ucciderli in quel momento e in quel luogo.
Composta di un solo capitolo, la storia di Madhu e Kaitabha è una concisa reinterpretazione dell’antico mito vaisnava che troviamo nel Mahābhāratha ed in altre fonti. Nei primi scritti, Visnu è il grande eroe e supremo Signore che sconfisse gli asura con la sua forza.
Nel Devîmahātmya, la suprema Devi tiene in suo potere Visnu addormentato fino a quando Brahma non le canta un inno. Quando vede che la battaglia di Visnu contro Madhu e Kaitabha è senza vittoria alcuna, la Dea interviene ancora. Nelle versioni Vaisnava, l’orgoglio degli asura sorge come conseguenza del loro enorme potere, ma nel Devîmāhātmya è l’illusione di Mahāmāyā che inganna la coppia e li induce a segnare la propria fine.
Come detto precedentemente, il mito stabilisce la Devî come massimo potere dell’universo dal quale ogni dio è dipendente. I brutali Madhu e Kaitabha hanno decretato da soli, con la loro stupidità, la propria fine, e ovviamene il messaggio è che l’orgoglio precede la caduta. I loro impulsi distruttivi, la rabbia e la forza brutale rappresentano gli aspetti bassi della natura umana. I due demoni simboleggiano Tamas, una delle tre energie fondamentali (guṇas)) che pervadono tutta la creazione. Per combattere questa forza negativa la Devî appare anche in una manifestazione tamasica come Mahāmāya “l’oscura Dea” (DM 1:89) che getta il suo velo di illusione e di oscurità sulla luce della verità.
L’inno di Brahma (DM 1:73-87), indirizzato alla Devî tamasica nel suo aspetto cosmogonico, rivela la comprensione profonda della natura della realtà divina e della continua evoluzione dell’universo. I versi iniziali affermano la piena trascendenza della Divina Madre e la identificano come creatrice, conservatrice e distruttrice del cosmo. Ella è sia consapevolezza che creatività, il substrato dell’esistenza e il grande potere illusorio che proietta il mondo fuori da se stessa. Ella è fonte di ogni bene e male, di radiante splendore e di oscurità terrificante, infine ella è l’ineffabile gioia oltre ogni dualità.
Il Devîmahātmya, avendo già sottolineato che nulla in questo mondo è come sembra, spiega l’origine dell’universo con il sorprendente paradosso che il mondo è creato con un atto di auto-occultamento (āvaraṇa) e proiezione (vikṣepa). La māyā della Suprema Dea cela la propria infinitezza ed è causa dell’emanazione dell’universo di nome e forma (māmarūpa) dalla sua coscienza illimitata. “Ella è eterna, avendo il mondo la sua forma” dice Medhas (DM 1:64). Questo verso appartiene inequivocabilmente alla tradizione Śākta non dualista e afferma una continuità ontologica tra la realtà divina indifferenziata e la sua manifestazione come universo materiale.
La Devî è inoltre prakrti (DM 1,78) comunemente tradotta come “materia primordiale” o “natura”. Come sostantivo verbale significa letteralmente “facente all’inizio” (mia traduzione: forma originaria), prakrti tuttavia non indica la materia inerte e insenziente causa, ma un processo dinamico dotato di consapevolezza.
Latenti nell’immanifestata prakrti sono le tre energie di base, i guna. Durante i periodi ciclici in cui l’universo non è manifesto, i guna esistono in uno stato di perfetto equilibrio. Quando Devî disturba questo equilibrio produce una vibrazione cosmica, una manifestazione di energia che approssimativamente corrisponde al suono della sillaba OM. L’attivazione dei guna è il primo passo verso la diversificazione nella prakrti – il primo evento alla base del processo cosmico di trasformazione da potenziale a reale.
I guna – tamas, rajas e sattva – sono le tre energie di base e le loro complesse interazioni creano l’universo fisico. Tamas è inerzia. La parola sanscrita significa “oscurità fisica e mentale” e la sua forza si manifesta come pesantezza, ottusità, ignoranza, azioni errate ed ogni condotta umana negativa. Rajas è movimento. La parola significa “penombra”, ovvero la situazione intermedia tra oscurità e luce e la forza che rappresenta si manifesta come irrequietezza, impurità, urgenza e passione. Sattva è equilibrio. La parola significa “esistente” o “che è vero”. Sattva non è la realtà stessa, ma rappresenta la tensione verso la realtà, e la sua manifestazione include luce, calma, quiete, purezza, bontà, saggezza. Tamas vela; sattva rivela, e rajas permette a queste forze polarizzatrici di interagire. Quali forze operative alla base dell’universo, i tre guna determinano ogni cosa dalla struttura fisica della materia alle piccolezze del comportamento umano. Considerare la materia minerale inanimata come priva di coscienza e la vita vegetale limitata in consapevolezza vuol dire ignorare che tutto ciò che esiste è il risultato delle forme assunte dalla suprema Śakti attraverso i suoi guna. I minerali sono intensamente tamasici, ma la loro coscienza così fortemente oscurata è osservabile nella densità della struttura degli atomi e particelle di cui si compongono. All’altro capo dello spettro osservabile vi è la consapevolezza, impregnata di sattva, del veggente che ha avuto esperienza del Divino. Il Devîmāhåtmya parla di tutto l’universo, mobile e immobile, quale divina manifestazione, nella quale nulla è privo di coscienza.
La materia, percepita come oggetto solido nello spazio e nel tempo è infatti una forma di energia relativamente stabile, finemente organizzata in sistemi di molti tipi di particelle subatomiche o onde che sono esse stesse fatte di ancora più piccoli quanti di energia. A grandi linee fisica quantistica e filosofia Śākta concordano su una visione dell’universo fisico come manifestazione di energia. Nello stesso modo in cui quanti di energia in vibrazione formano unità di materia sempre più complesse in grado di produrre l’intero cosmo, così i tre guna combinati e ricombinanti con crescente complessità strutturano l’intero universo materiale e gli esseri che lo abitano. Gli scienziati dichiarano che la quantità di energia presente nell’universo è costante; nel tardo XIX secolo Swami Vivekanda scrisse che la Divina Madre è la “somma totale dell’energia presente nell’universo”. Mentre la scienza continua a cercare le prove di quella semplicità originaria – la perfetta e ininterrotta simmetria prima dell’inizio della creazione, prima che l’energia si cristallizzasse in materia – la filosofia Śākta già riconosceva che la forma ultima della materia è energia e che la forma ultima dell’energia è la coscienza.
Ādyā Śakti – il potere primordiale privo di ogni dualità – è la realtà ultima, una forma senza forma per noi inconcepibile, che non è né maschio né femmina né neutro, ma è pura, indifferenziata esistenza-coscienza-beatitudine (saccidānanda). Sebbene priva di inizio, Ādya Śakti è l’inizio di tutto. La filosofia Śākta, allo stesso modo delle Upaniśad, ritiene che Brahman e Māyā, da essa chiamati Śiva e Śakti, siano una unità indivisibile, che è chiamata Śiva quando è vissuta come il piano immutabile dell’esistenza e Śakti quando è esperienza del potere dinamico del divenire.
Questo potere del divenire (māyāśakti), che si manifesta come mente e materia, è il potere attraverso il quale l’infinito immutabile indossa i veli mutevoli del tempo e dello spazio e diviene un universo che non è altro che la forma risplendente del senza forma (śunyasākara ), un universo dove spirito, mente e materia sono uniti in un tutt’uno.
Anche se compilato a partire da diverse fonti, il Devīmāhātmya rivela una base filosofica coerente, mentre i commentatori successivi hanno esercitato un ampio margine di manovra nel tentativo di rivelarne i segreti a partire dalle diverse posizioni filosofiche di appartenenza. I due commentari più importanti sono il Guptavatī (“Sulla conferma di ciò che è nascosto”), scritto intorno al 1741 da Bhāskarararāya, e quello leggermente precedente ad opera di Nāgoji Bhatta. Mentre Bhaṭṭa si rifaceva in gran parte alla pratica consolidata di interpretare il Devīmāmāhātmya secondo la scuola Vedānta, Bhāskarararāya è stato il primo commentatore a scrivere da una prospettiva tantrica.
Sebbene la filosofia Śākta e l’Advaita Vedānta del filosofo-santo dell’ottavo secolo Śaṁkarācārya siano entrambe non dualistiche nel concordare sul fatto che un’unica realtà sia alla base di tutte le diversità, esse giungono a conclusioni radicalmente diverse sulla natura del mondo. Per Śaṁkara, il mondo non è né reale né irreale. Il suo non dualismo pone una gerarchia ontologica dell’assolutamente reale o trascendentale (pāramārthika), che è il Brahman non duale; l’empirico (vyāvahārika), che è l’universo oggettivo dell’esperienza umana, che si trova a metà strada tra la verità assoluta e la completa falsità; e l’apparente o illusorio (prātibhāsika), che include illusioni, allucinazioni e sogni. Secondo il processo noto come sublazione, una nuova esperienza confuta quanto precedentemente sperimentato come realtà. Per esempio, un sogno si rivela irreale quando il dormiente ritorna allo stato di veglia.
Allo stesso modo, l’esperienza dell’universo fenomenico e oggettivo è sublimata dall’esperienza di Brahman, e l’universo scompare. Ma poiché il Brahman, l’Assoluto, non può essere sublato da nessun’altra esperienza, è la realtà ultima e unica.
Il Brahman assoluto è nirguṇa, o senza qualità, e secondo Śaṁkara l’universo è solo una sovrapposizione (adhyāsa) di quella realtà immutabile. Questa dottrina, nota come vivartavāda, spiega l’universo come una semplice tendenza a confondere una cosa per un’altra. L’esempio classico è quello di vedere una corda nella penombra e pensare che sia un serpente. Finché dura la percezione erronea, il serpente è reale per chi lo percepisce, che quindi reagisce di conseguenza. Ma il serpente e la paura di esso svaniscono quando la luce lo rivela come una corda. Allo stesso modo, il mondo empirico svanisce con l’esperienza dell’infinito Brahman.
La filosofia di Śaṁkara non considera il mondo come pura illusione, ma come un’esperienza imperfetta della realtà attraverso i veli del tempo e dello spazio di māyā, e questa contiguità esiste solo nella sua fugace esperienza.
In contrasto con la dottrina vivartavāda di Śaṁkara, il Guptavatī di Bhāskarararāya e il Devīmāhātmya sviluppano la dottrina pariṇāmavāda, il mondo come una vera e propria trasformazione della divinità. L’analogia classica che esprime questa visione è quella di un filo che viene lavorato per creare un tessuto. La causa (filo) si trasforma in effetto (tessuto) attraverso un cambiamento di forma ma non di sostanza. Le Upaniṣad sostengono la visione Śākta dell’universo come reale. Il pronunciamento nella Chāndogyopaniṣad, Sarvaṁ khalvidaṁ brahma, “Veramente tutto questo [universo] è Brahman” (ChU 3.14.1) continua: “Da ciò hanno origine tutte le cose, in ciò si dissolvono, e da ciò sono sostenute”. La Śvetāśvataropaniṣad afferma l’identità dell’Assoluto, del relativo e della māyā che colma il divario, e dichiara tutti e tre essere Brahman (ŚU 1.9, 12). Attraverso un mistero che va oltre la capacità di comprensione della mente, Śakti diventa l’universo molteplice mentre Śiva rimane unitario e trascendentale, e la realtà divina comprende sia l’esperienza del tutto che del parziale nel tutto. Per il Śākta tutto esiste nell’infinita Śakti, e tutte le limitazioni all’interno della sua interezza non rappresentano altro che i suoi molteplici aspetti. In stridente contrasto, per Śaṁkara la realtà assoluta di Brahman risiede nella sua immutabilità, che non ammette alcuna possibilità di imperfezione insita nel cambiamento.
In verità, nessuna filosofia può portare la mente umana oltre il principio finitizzante di māyā per abbracciare la coscienza infinita e trascendente. Si può accettare la posizione di Śaṁkara, secondo cui il mondo non è più reale del serpente percepito erroneamente come corda, oppure si può propendere per la posizione Śākta, per la quale l’Immutabile si trasforma in qualche modo nei mutabili Molti pur rimanendo uno e immutabile.
In entrambi i casi, c’è una soglia che la ragione non può oltrepassare, dove la saggezza diventa silenzio, e l’esperienza inesprimibile da sola può rivelare la sua verità.
Ora, qual è il rapporto di questa coscienza suprema con il mondo dell’esperienza umana? Senza la realizzazione del Sé, gli esseri umani vivono, illudendosi, in un universo proiettato da Mahāmāyā, che è sia “la grande dea che la grande demone” (DM 1.77). L’universo è un caleidoscopio di possibilità illimitate, di bellezza mozzafiato e orrore spaventoso, dove la vita oscilla tra piacere e dolore, felicità e miseria, successo e fallimento. In un mondo così, nasce la necessità di fare delle scelte.
Se la caratterizzazione iniziale di Medhas della Devī nel suo aspetto tamasico ispira la contemplazione filosofica sulla natura della realtà, la sua rappresentazione di lei nel suo aspetto rajasico ispira la visione di una dea attivamente coinvolta nella sua creazione. Qui si evidenzia la sua duplice natura di madre compassionevole degna di devozione e di guerriera protettrice intenta a vincere il bene sul male.
La seconda storia di Medhas, raccontata nei capitoli dal 2 al 4, costituisce la seconda carita del Devīmāhātmya.
MAHIṢĀSURAMARDINĪ
In un tempo remoto, le forze demoniache di Mahiṣa, il demone bufalo, avevano combattuto contro le forze celesti di Indra per 100 anni e avevano sconfitto gli dei. Scacciati dal cielo, gli dei destituiti richiesero l’aiuto di Viṣṇu e Śiva. Fu così che un grande splendore si emanò prima dal volto adirato di Viṣṇu e poi da Brahmā e Śiva. Poi da tutti gli altri dei, una luce si levò e si unì in una dea fiammegginate, alla quale ogni dio conferì un’arma o un ornamento simbolico della sua potenza. Sentendo il turbamento, Mahiṣa e le sue orde di demoni si precipitarono sulla scena e videro la Devī Durgā in tutto il suo stupefacente splendore. Milioni e milioni di asura si lanciarono all’attacco, ma lei serenamente spezzava le loro armi come se fosse un gioco. Ogni suo respiro emanava legioni, e in mezzo a una orribile carneficina la Devī trionfò vittoriosa. Poi Durgā distrusse i generali di Mahiṣa uno ad uno, finché venne il momento di affrontare il demone Bufalo da sola. Con rabbia scuoteva la terra con gli zoccoli, urlando feroce, e squarciava le nuvole con le sue corna. Ogni volta che Durgā lo colpiva, cambiava forma, da bufalo a leone a uomo a elefante e di nuovo a bufalo, eludendo i suoi colpi mortali fino a quando lei gli saltò addosso, gli bloccò il collo sotto i piedi e lo trafisse con la lancia. Poi dalla bocca del Bufalo fuoriuscì metà dell’orrenda e vera forma di Mahiṣa e Devī Durgā lo decapitò con un solo colpo della sua possente spada.
Nei secoli precedenti la composizione del Devīmāhātmya, la dea Durgā è emersa nel movimento Śākta come una delle forme principali della Devī. Sembra essere di origine indigena, e molti primi riferimenti la associano ai Monti Vindhya a sud della Valle dell’Indo, una regione popolata da tribù ostili. La parola durga (“di difficile accesso”) compare nel Ṛgveda solo come aggettivo oppure sostantivo neutro o maschile ma mai come nome femminile, e questa evidenza testuale suggerisce che Durgā è stata assorbita nel pantheon vedico dopo il periodo dei Saṁhitā. Appare per la prima volta come dea nella letteratura vedica nel Taittirīyāraṇyaka, che la caratterizza come “la fiammeggiante”, legata al potere di Savitṛ e di Agni, gli dei del sole e del fuoco (TA 10.1). Le prime tracce del mito che definisce Durgā, riguardante l’uccisione del demone bufalo, si trovano in sei statue e in una placca di terracotta dello stato indiano nord-occidentale del Rajasthan. Risalenti al primo secolo a.C. e agli inizi del IV secolo d.C., illustrano il momento culminante del mito e raffigurano Mahiṣāsuramardinī -Durgā che uccide il demone Bufalo – come una dea armata di tridente e lancia in combattimento con un bufalo. La scena mostra inoltre un leone che la accompagna.
Sebbene l’origine ultima del mito rimanga sconosciuta, prove indiziarie la collocano in un passato estremamente remoto. Ricordiamo che in Baluchistan sono state ritrovate immagini pre-Harappiane di una dea formidabile in relazione a quelle di un toro selvaggio e sono state interpretate come simboli credibili del bene che vince il male. Una tale interpretazione trova sostegno nell’opera dell’archeologo Jacques Cauvin, il quale sostiene che il bovino selvatico maschio terrorizzava il popolo neolitico con la sua forza bruta e la sua ferocia distruttiva, tanto da diventare simbolo universale del male, del caos che minacciava il fulcro della pace delle società agricole sedentarie.
Senza prove dirette è impossibile attribuire un’origine così remota alla storia di Mahiṣāsura, ma non possiamo escludere la possibilità che uno dei miti più accattivanti dell’Induismo conservi una memoria culturale primordiale.
Le successive tavolette di terracotta di Harappa mostrano una figura maschile che uccide un bufalo d’acqua nel modo descritto nel Devīmāhātmya, bloccandone la testa sotto i piedi e conficcando una lancia nella spalla; questo atto avviene in presenza della divinità maschile locale, che si suppone sia un proto-Śiva, seduta in posizione yogica.
Questa evidenza difficilmente suggerisce una connessione diretta con Durgā, ma diventa degna di nota alla luce del più antico racconto letterario del mito, conservato nel Mahābhārata. Lì Mahiṣa viene ucciso dal figlio di Śiva, Skanda (MBh 3.221).20 Nel Harivaṁśa, un successivo supplemento al Mahābhārata, l’uccisore di Mahiṣa viene riconosciuto una volta come Śiva stesso e tre volte come dea senza nome. Il Vāmanapurāṇa, che potrebbe essere successivo al Devīmāhātmya, contiene due racconti dell’uccisione, uno associato a Skanda e uno a Durgā. Nato da origini ancora incerte, il mito è rimasto per lungo tempo fluido nell’attribuire a Skanda, Śiva, o a una dea senza nome l’uccisione di Mahiṣāsura, fino a quando la sua formulazione nel Devīmāhātmya per la prima volta ha effettivamente collegato i nomi di Mahiṣa e Durgā.
L’argomento a favore dell’antichità di Durgā diventa ancora più convincente alla luce del suo legame con un’altra dea antica, Vindhyavāsinī. Questa identificazione è coerente in due inni interpolati nel Mahābhārata, il Durgāstava (in MBh 4.5) e il Durgāstotra (in MBh 6.22), e in tre inni del Harivaṁśa. Tra questi ultimi, l’Elogio di Nidrā di Viṣṇu esalta Vindhyavāsinī per aver sventato il complotto di Kaṁsa per uccidere il neonato Kṛṣṇa (HV 47.38-57). Poi una successiva aggiunta di cinquantotto righe all’inno (HV Appendice I, n. 8) non solo chiarisce che Vindhyavāsinī e Durgāsinī sono la stessa dea, ma la identifica anche nella riga 32 con Aditi, la madre universale del Ṛgveda.
Questo è molto significativo, considerando che i riferimenti ad Aditi nei Ṛgveda possono essere le più antiche testimonianze superstiti di qualsiasi dea della tradizione letteraria indiana.
L’associazione di Durgā con i temi Vaiṣṇava sulla distruzione della malvagità e la protezione della virtù è un altro filo conduttore della Durgāstava e della Durgāstotra. Il cantore di questo inno del Durgāstava è Yudhiṣṭhira, il re espropriato la cui situazione assomiglia a quella di Suratha. Significativamente, il Durgāstotra, uno dei primi inni sanscriti alla Devī, avviene immediatamente prima dei 18 capitoli che formano la Bhagavadgītā.
Arjuna, in procinto di impegnarsi in battaglia a Kurukṣetra, è consigliato da Kṛṣṇa di recitare il Durgāstotra per assicurarsi la vittoria. Arjuna scende dal suo carro e invoca la Devī come Kālī, Bhadrakālī, Caṇḍī, e Durgā, e con altri nomi ed epiteti che ritroviamo nel Devīmāhātmya. Insieme, l’estatica lode di Yudhiṣṭhira e l’invocazione di Arjuna presentano una visione di Durgā come una dea oscura e splendente, la distruttrice di Kaiṭabhaand Mahiṣāsura, degna di essere adorata dagli dei vedici. Dotata di ogni sorta di armi e di ornamenti, concede la vittoria in battaglia e rimuove i fardelli umani. Molte sono le grazie che concede a coloro che cercano rifugio in lei.
I due inni condividono con il Devīmāhātmya una moltitudine di temi, immagini ed epiteti, anche interi passaggi strettamente correlati, soprattutto per quanto riguarda le promesse di protezione e di benedizione della Devī. Così come l’enumerazione del testo del Devīmāmāhātmya in settecento versi per conformarsi al numero simile della Bhagavadgītā.
Nonostante il suo titolo alternativo, Śrī Durgāsaptaśatī (“Settecento versi a Śrī Durgā”), il Devīmāhātmya in realtà consiste di meno di seicento distici completi (ślokas). Per arrivare ai settecento necessari, i redattori hanno variamente numerato alcune linee singole, linee parziali e frasi interlocutorie (“così e così detto”) come śloka. Per poter tracciare un tale parallelo con la Bhagavadgītā, devono aver avuto una ragione convincente. In effetti ce l’avevano.
Intendevano così equiparare l’attività di Devī Durgā al ruolo redentore di Śrī Kṛṣṇa nella religione Vaiṣṇava. L’idea dell’intervento divino nelle questioni mondane appartiene alla tradizione dell’avatāra Vaiṣṇava, o divinità incarnata. Nella Bhagavadgītā (BhG 4.6-8) Kṛṣṇa dichiara che ogni volta che la giustizia declina e il male prolifera, egli nasce nel mondo per proteggere il bene, per distruggere la malvagità e per ristabilire l’ordine naturale, il dharma che sostiene (dhāryate) il mondo.
Nel Mahābhārata, l’intervento protettivo è un ruolo attribuito anche alla Devī. Su consiglio di Kṛṣṇa, Arjuna invoca Durgā con un inno immediatamente prima della battaglia di Kurukṣetra, dove appare e assicura la vittoria. E proprio come le parole iniziali del Bhagavadgītā dichiarano che il campo di Kurukṣetra è una metafora del campo del dharma – il campo di battaglia della vita umana con il suo conflitto perpetuo tra il bene e il male – i campi di battaglia del Devīmāhātmya incarnano un simbolismo parallelo. Paragonare il Devīmāhātmya alla Bhagavadgītā significa rafforzare il ruolo protettivo di redentrice della Devī e la sua grazia salvifica di fronte alle avversità. Ogni volta che il male prevale sul bene e sconvolge l’ordine naturale, la Devì, che è la madre universale, protettrice e dea salvifica, interviene.
La seconda unità del Devīmāhātmya ha dimensioni teologiche e pratiche nel rappresentare la Devì come la Durgā salvifica, e la storia è destinata a Suratha.
Avendo perso il suo regno a causa dei demoni, egli può identificarsi con gli dei spodestati; avendo governato con l’autorità divina, vincolato dal dovere di tenere in piedi il dharma, può identificarsi con il suo rovesciamento.
Gli asura e gli dei che assaltano il cielo rappresentano le tendenze buone e cattive che pervadono il mondo in perpetua opposizione. La furia di Mahiṣa simboleggia il senso di attaccamento basato sull’ego che affligge Suratha sul suo regno perduto. Il comportamento del demone bufalo incarna il guṇa rajas, l’energia ardente e attiva che si manifesta come irrequietezza, desiderio, rabbia e passione corrosiva. La Devī appare anche nel suo aspetto rajasico, come lo splendore intrinseco (tejas) degli dei maschili. E lei non è subordinata a nessuno di loro. Le loro forze e virtù individuali, che emergono dai loro corpi con ardente brillantezza e si fondono in un’unica forma femminile suprema, non sono che aspetti della sua indivisa potenza. L’episodio del trionfo di Durgā sul male è il suo momento decisivo, un mito così potente da essere celebrato nella scultura e nella pittura da almeno duemila anni. Al di là della vittoria morale, l’immaginazione stratificata del mito ha implicazioni psicologiche e spirituali più profonde. Come metafora, Mahiṣa rappresenta più della rabbia, per quanto monumentale. Ogni volta che Durgā attacca, il demone bufalo sfugge ai suoi colpi mortali usando lo scudo protettivo delle sue forme mutevoli. Fino a quando non rivela la sua vera forma, rimane inafferrabile e apparentemente invincibile. Allo stesso modo, l’illusione umana indossa una serie di maschere per nascondere e proteggere un ego governato da attaccamento, avversione e paura radicata. I demoni personali continueranno a insultarsi in una forma o nell’altra fino a quando non saranno riconosciuti per quello che sono.
Naturalmente, la riluttanza di Mahiṣa a rivelare se stesso deriva da un senso di autoconservazione, e Durgā forza la rivelazione trafiggendo il suo fianco con la sua lancia, che simboleggia la luce penetrante della conoscenza superiore.
Quando Mahiṣa emerge nella sua vera forma, Durgā lo decapita con la sua spada, metafora della viveka, la capacità di discernere tra l’apparente e il reale, il transitorio e l’eterno. L’esperienza della dualità e dell’ego finito nasce dal moha (attaccamento), la limitazione della coscienza. Senza una comprensione non dualistica, la presenza del male nel mondo rimane una questione fastidiosa. Alcune religioni dualistiche cercano una soluzione riconoscendo Dio come fonte del bene e inventando il diavolo come fonte del male, ma così facendo creano l’ulteriore problema di un Dio diminuito, che non è più l’essere supremo, ma uno dei due avversari che si limitano a vicenda. Il semplice fatto è che il bene e il male coesistono nel mondo relativo e nessuno dei due è possibile senza che l’altro lo definisca. Praticamente e filosoficamente, il male è ciò che allontana dal Divino, e il bene è ciò che conduce verso di esso. Per quanto riguarda l’ego, quando la Devī entra nella sua creazione per viverla come il suo gioco divino (līlā), la sua coscienza infinita appare frammentata come centri finiti nel tempo e nello spazio che definiscono tutto nella loro esperienza in termini di “io, io e il mio” e i loro corollari negativi. Inevitabilmente, gli interessi di un ego si scontrano con quelli di un altro, e sorge la necessità di scelte morali tra l’egocentrismo divisorio e il potere unificante dell’amore disinteressato. L’uccisione di Mahiṣāsura da parte di Durgā simboleggia la conquista dell’attaccamento basato sull’ego e tutto il suo conseguente dolore. Non c’è da stupirsi che l’espressione finale di Mahiṣa, guardando il suo uccisore che brandisce la spada, sia un’espressione di rabbiosa soggezione.
Nell’eloquente e riccamente dettagliato Śakrādistuti (DM 4.3-27) che segue, Indra e gli altri dei lodano la supremazia e la trascendenza di Durgā prima di elaborare il significato dell’uccisione di Mahiṣa, che si concentra sulla natura salvifica del potere del Devī e sulla sua compassione incondizionata. Il suo scopo è quello di preservare l’ordine morale, e a tal fine appare come “fortuna nelle dimore dei virtuosi e sventura nelle dimore dei malvagi” (DM 4.5), concedendo abbondanti benedizioni e sottomettendo la cattiva condotta. “Sempre intento alla benevolenza verso tutti” (DM 4.17), rivela anche il suo vasto potere distruttivo come in definitiva compassionevole, poiché, uccidendo quei nemici del mondo che “possono aver commesso abbastanza male da tenerli a lungo nel tormento” (DM 4.18), li riscatta con il tocco purificatore delle sue armi affinché “possano raggiungere i mondi superiori” (DM 4.19). Poiché il bene e il male esistono solo l’uno rispetto all’altro, nessun malfattore incontra la dannazione eterna.
Alla fine, tutti possono accedere alla benedizione della Madre Divina.
La promessa del Devī di ritornare ogni volta che viene ricordata dagli dei o dall’umanità in tempi di sofferenza spinge Medhas ad annunciare un’altra storia e così inizia il carita più lungo ed elaborato dell’intero Devīmāhātmya, che occupa i capitoli dal V al XIII.
LA GRANDE MADRE — UNA E MOLTE
Molto tempo fa, due arroganti asura, i fratelli Śumbha e Niśumbha, sottrassero a Indra il dominio sui tre mondi, così che, per l’ennesima volta, gli dei finirono spodestati. La Devī aveva promesso che, ogni qual volta fosse stata ricordata nei momenti di sofferenza, sarebbe apparsa ponendo fine alla sventura, ed è così che gli dei decisero di invocarne il nome.
Ella quindi emerse splendente dal corpo della consorte di Śiva, Pārvatī, per prendere dimora sull’Himālaya. In men che non si dica la sua incredibile bellezza attirò l’attenzione di Caṇḍa e Muṇḍa, i due servitori di Śumbha e Niśumbha, i quali pensarono che, dal momento che i loro padroni avevano già sottratto quanto di più prezioso in possesso agli dei, non potevano non appropriarsi anche della più bella tra le dee. Śumbha inviò quindi il suo messaggero, Sugrīva, per convincere con l’inganno la Devī a venire da lui e da Niśumbha. Ma Sugrīva tornò indietro con una sfida, poiché la Devi aveva giurato molto tempo addietro che avrebbe sposato solo colui il quale l’avesse sconfitta in battaglia. Śumbha allora ordinò al capo Dhūmralocana di andare a prenderla con la forza, e constatato il fallimento della missione, Caṇḍa e Muṇḍa furono mandati a prenderla. La Devī li vide quindi avvicinarsi con un immenso esercito al seguito, aggrottò le sopracciglia e dalla sua fronte balzò fuori la tremenda dea Kālī, che massacrò le orde demoniache.
A Śumbha non rimase che schierare i clan di tutti gli asura e, a sua volta, la Devī evocò le sue śakti, sette temibili dee nate dai corpi degli dei. Dal suo stesso corpo poi emerse la più terrificante delle śakti, Śivadūtī, inviando il grande Signore Śiva in persona come messaggero a Śumbha e Niśumbha per avvertirli delle conseguenze se avessero deciso di proseguire la battaglia. I due arroganti asura ignorarono l’avvertimento e lo scontro, di una ferocia senza precedenti, si concluse in un bagno di sangue.
Mentre gli altri demoni sopravvissuti fuggirono davanti alla furia delle śakti, il grande asura Raktabīja si diresse a grandi passi sul campo di battaglia. Ogni volta che una goccia del suo sangue toccava terra, si trasformava in un’asura di pari dimensioni e forza, e presto la Devī si trovò nuovamente a fronteggiare un numero impressionante di nemici. Allora il terrore si impadronì degli dei, ma la Devi si limitò a ridere mentre Kālī iniziò a bere le gocce di sangue e le asura che da esse nascevano. E dalle gocce che beveva nessuna asura rinasceva, finché il potente Raktabīja, prosciugato completamente dal proprio sangue, cadde morto.
Quindi Śumbha e Niśumbha stessi scesero in campo contro la Devī e le sue śakti fino a che anche Niśumbha fu ucciso. Pieno di rabbia e di dolore, Śumbha accusò la Devī di aver fatto affidamento sulla forza degli altri per vincere, ma la sua risposta fu che le śakti altro non erano che proiezioni del proprio potere. Per dimostrarlo le richiamò a sé, restando sola contro di lui e, al culmine della battaglia, i due balzarono in cielo e combatterono a mezz’aria fino a quando la Devī non scaraventò il grande Śumbha a terra. L’asura morì schiantandosi a terra, il cielo si schiarì lasciando emergere un glorioso sole, e l’universo giacque in una calma luminosa. Gli dei tesserono le lodi alla Devi in un magnifico inno di ringraziamento, e fu così che ella promise di proteggere e benedire chiunque la invochi con inni, chieda la distruzione degli asura e la veneri con devozione.
Dei tre miti del Devīmāhātmya, la storia di Śumbha e Niśumbha è la meno attestata nella letteratura sanscrita. Con ogni probabilità, essa ha avuto origine tra i popoli aborigeni adoratori della dea che abitavano l’India del Nord, dove tutt’oggi si preservano queste antiche tradizioni. Da quelle stesse popolazioni nacquero le leggende di Kṛṣṇa, l’amato pastore Gopala, e le poche tracce di Śumbha e Niśumbha nella letteratura sanscrita prima del Devīmāhātmya appaiono in connessione con l’emergere di Kṛṣṇa Gopāla, successivamente assorbito nelle trame del Vaiṣṇava.
Dallo stesso ambiente Vaiṣṇava proviene ancora un altro mito, brevemente accennato nel Devīmāhātmya (DM 11.41–42): la storia della nascita di Kṛṣṇa e il ruolo svolto dalla dea Vindhyavāsinī. Era stato predetto al malvagio re Kaṁsa che sua sorella Devakī avrebbe dato alla luce un bambino per mano del quale sarebbe morto. Preparandosi a nascere come Kṛṣṇa, il grande Signore Viṣṇu chiese alla dea Yoganidrā (Mahāmāyā) di venire alla luce alla stessa ora dal pastore Nanda e da sua moglie Yasoda, e con l’aiuto del potere ingannatore di Yoganidrā, i bambini furono scambiati alla nascita. Quando Kaṁsa si precipitò al fianco di Devakī per ucciderne il figlio appena nato, il bambino sfuggì alla sua presa per assumere la classica forma a otto braccia della dea. Dopo aver comunicato a Kaṁsa che il suo uccisore era nato, Yoganidrā si ritirò sui monti Vindhya, dove è ancora venerata come Vindhyavāsinī.
Questo mito dimostra che la dea Yoganidrā, o Mahāmāyā, appartiene a una tradizione preesistente successivamente incorporata nelle prime leggende Vaiṣṇava. Allo stesso modo, inni interpolati nel Mahābhārata e nell’Harivaṁśa descrivono Mahādevī, la Grande Dea che si incarna per aiutare Viṣṇu, come avente dimora permanente nelle montagne Vindhya, una designazione che la colloca tra i popoli tribali non vedici adoratori della natura selvaggia. Tuttavia, l’associazione Vaiṣṇava di Vindhyavāsinī non è esclusiva; il Matsyapurāna, uno dei sei Śaiva Purāṇa, considera lei, Caṇḍikā e Kālī come tre manifestazioni della Devī, ognuna delle quali è, di nuovo, connessa con le regioni montuose più selvagge.
Oggi, il complesso del tempio di Vindhyavāsinī domina il villaggio indiano centro-settentrionale di Vindhyācal (Uttar Pradesh). Appena a nord di un padiglione che reca sulle pareti di marmo il testo di recente incisione del Devīmāhātmya, un santuario di pietra antico e poco appariscente ospita la dea. Ella è raffigurata sopra un leone e i suoi due grandi occhi argentati campeggiano su un volto nero, dalle fattezze di uccello. La sua sorprendente fisionomia ricorda le statuine di terracotta con volto di uccello di Harappa e Mohenjo-daro, che a loro volta guardano alle ben più antiche dee con testa d’uccello del Baluchistan, e da lì, con un ulteriore balzo indietro nel tempo, fino ad un passato per noi inconcepibilmente remoto.
Nel momento in cui il mito di Śumbha e Nīśumbha raggiunge la sua forma definitiva nel Devîmāhātmya, la Devî aveva sostituito Krsna Gopāla quale loro assassino oppure aveva ripreso il suo ruolo originario. Inoltre, la versione del mito presentata nel Devîmāhātmya contiene dettagli che segnalano una influenza śaiva, come per esempio lo spostamento dai monti Vindhya all’Himalaya (dimora di Śiva), l’emergere della Devî dal corpo consorte di Śiva e l’importanza di Kālī nella narrazione.
Kālī è descritta nel settimo capitolo così emaciata che a malapena la carne ne nasconde le ossa. Zanne bianche sporgono dalla bocca che, spalancata, gronda sangue ed incornicia una lingua rossastra e penzolante. Rossi sono anche i suoi occhi, che emergono dalla faccia nera. Possiamo pensare che la predominanza di nero, rosso e bianco – i colori di tamas, rajas e sattva – indichino Kālī non quale dea secondaria, bensì la Suprema Madre dell’Universo (Jagadamba) nella quale risiedono i tre guna. In breve, ella è la risplendente Devî in un’altra forma, una forma oscura.
Manifestandosi a Śumbha per contrastarne la crescente malvagità, ella porta con sé quel bastone sormontato da un teschio che tradizionalmente l’accompagna in battaglia. Il bastone, che richiama certa tradizione sciamanica, supporta la presunta orgine di Kālī tra le società tribali delle regioni montagnose dell’India. Anche se le sue vere origini restano avvolte dal mistero, la sua pelle scura può essere un riferimento alla nera e fertile terra, e il suo aspetto duale, di creatrice e distruttrice della vita, indica una origine in un tempo molto antico. Conformemente al suo aspetto predominantemente spaventoso, i primi templi di Kālī erano situati ai margini della civiltà, spesso vicino a foreste e aree di cremazione.
Il suo nome ha origine dall’aggettivo femminile kālī, che significa “nero” o “nero blu”. È probabilmente legato al sostantivo kāla (tempo), che rimanda all’idea di Kālī come tempo incessantemente circolare, la divoratrice implacabile che porta ogni cosa alla fine. Il nome appare per la prima volta nella letteratura sanscrita 2.500 anni fa nelle Mundakopaniśad, dove è identificata con una delle sette lingue fiammeggianti di Agni che divorano l’offerta di burro chiarificato tipica del sacrificio vedico (MU 1.2.4). Si tratta di una prova chiaramente non sufficiente per confermare o almeno suggerire che Kali in origine fosse una śakti di Agni, ma non può sfuggirci il parallelo tra il fuoco che dissolve la materia fino a farla tornare di nuovo energia – nella forma di calore e luce – e Kālī la distruttrice, che dissolve l’universo fisico perché torni śakti in-diversificata.
Lo stesso verso delle Upaniśad designa un’altra delle sette lingue di Agni come Karālī (“formidabile, terrificante, terribile con la bocca spalancata ed i denti sporgenti”). Questa parola appare due volte nell’inno dinale del Devîmāhātmya e descrive Kālī dalla bocca terrificante (11.21) e Bradrakalī dal tridente fiammeggiante (11.26).
Kālī appare inequivocabilmente come dea nel Kathaka Grhyasūtra, un testo rituale del tardo periodo vedico che la pone tra gli déi vedici che sono invocati con offerta di profumo durante le cerimonie matrimoniali.
Durante il periodo epico, qualche tempo dopo il V sc AC, Kālī appare nel Mahābhārata. Quando l’accampamento dei fratelli Pāndava è attaccato una notte da Aśvathama armato di spada, il suo assalto letale appare opera di “Kālī dalla bocca sanguinante e dagli occhi iniettati di sangue, cosparsa di sangue ed ornata da ghirlande di teschi… incoronata e con un cappio in mano”. Ella, la Notte della Morte (Kālarātri), ride in modo beffardo mentre strangola uomini cavalli ed elefanti con il suo terribile laccio di morte (MBh 10,8,64-65).
Sebbene il passaggio continui descrivendo il massacro come atto di guerra tra esseri umani, è chiaro che che la feroce dea è in definitiva “l’agente della morte” che porta via coloro che sono stati uccisi.
Tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo la caratterizzazione di Kālī cambiò radicalmente, quando i tantrici bengalesi e poeti devozionali quali Rāmprasād e Kamalākānta la immaginarono in tutta la sua bellezza voluttuosa e iniziarono a rivolgersi a lei come Madre amorevole, universale e suprema realtà metafisica. Tale caratterizzazione di Kālī rimane a tutt’oggi quella predominante. L’ottavo capitolo del Devīmāhātmya descrive il modo in cui la Devī moltiplica la sua forza nel crescendo della battaglia, ovvero richiamando a sé sette śakti individuali dai corpi degli dei maschili. Le sette śakti assumono collettivamente il nome di mātṛgaṇa (“gruppo di madri”), Saptamātṛkās (“Sette Piccole Madri”) o, più semplicemente, Madri. Apprendiamo dal Bṛhat Saṁhitā, un testo contemporaneo al Devīmāhātmya, che nel sesto secolo esisteva un culto diffuso e alquanto potente incentrato su un gruppo di feroci dee, di solito in numero di sette. Lo stesso testo raccomanda che le loro raffigurazioni mostrino gli stessi simboli identificativi attribuiti agli dei di cui costituiscono la controparte. Le numerose prove iconografiche di questo periodo includono un pannello intagliato esposto in un tempio dedicato al culto delle Saptamātṛkās raffigurante le sette dee, a cui si accompagna un’iscrizione che invoca i benefici del loro potere protettivo. Come si evince nel Devīmāhātmya, la funzione delle Madri è quella di lottare per la preservazione del mondo.
Ma chi sono queste Madri? Quando le incontriamo nel Devīmāhātmya, molte delle loro caratteristiche sono già state assorbite e rielaborate dal pensiero brāhmaṇico e gli aspetti più violenti considerevolmente ridimensionati, ma non sono state sempre considerate così benevole. Soltanto uno o due secoli prima del Devīmāhātmya ingaggiavano infatti cruente battaglie con i demoni, identificandosi sempre più con le divinità maschili, e solo allora iniziarono a evolversi in forme differenziate riconoscibili come le sette śakti descritte nel nostro testo.
Prima di allora, le sette apparivano come figure uniformi. In anticipo sulla Devīmāhātmya di circa 500 anni, i riferimenti alle Madri negli strati successivi del Mahābhārata le collegano invariabilmente al dio della guerra Kārttikeya (Skanda) e le descrivono come dee minori particolarmente feroci e assetate di sangue in cui, paradossalmente, l’istinto materno è profondamente radicato. Il loro numero è spesso non specificato ma dev’essere molto grande, e sono ritratte non solo come infauste ma anche decisamente pericolose. Queste dee si configurano come predatrici di bambini, almeno fino a quando Kārttikeya non le persuade ad assumere un ruolo protettivo. E tuttavia, concede loro il diritto di tormentare i giovani fino all’età di sedici anni! I loro nomi, quando esistenti, non corrispondono ancora ai nomi presenti nel Devīmāhātmya.
Ancora prima, le Madri erano un gruppo indipendente di dee violente associate ai pericoli della gravidanza e del parto, alla mortalità infantile e alle malattie che affliggono i bambini piccoli. Molte di queste divinità sopravvivono fino ad oggi nella religione popolare dei villaggi indiani, dove ricevono ancora offerte di sangue per la loro pacificazione. Dato per certo che alcune caratteristiche della civiltà della valle dell’Indo persistono ancora oggi nei villaggi indiani, se guardiamo indietro di circa due millenni prima dei riferimenti nel Mahābhārata, scopriamo che alcuni dei sigilli di pietra di Harappa recano le immagini scolpite di sette figure identiche, tutte in fila, a volte tenendosi per mano. Avvolte in tuniche coordinate, con i capelli acconciati in una treccia e una piuma sulla testa, mostrano caratteristiche fisiche e abiti che ricordano gli uccelli, mentre i loro volti sono umani. Queste figure misteriose, che ci scrutano da oltre 4000 anni, potrebbero essere le prime rappresentazioni delle Sette Piccole Madri? Il Mahābhārata descrive le Madri come di carnagione scura, in grado di parlare diverse lingue e dimoranti montagne e grotte. Insieme, questi tratti suggeriscono che le Madri fossero presenti nella diaspora multietnica delle popolazioni della valle dell’Indo che si trasferirono nelle regioni periferiche più remote dopo aver abbandonato villaggi, paesi e città ormai condannati alla decadenza. Sebbene la cultura brāhmaṇica che ha prodotto il Mahābhārata considerasse con sospetto le Madri in quanto con molta probabilità non ariane, l’autore/gli autori del Devīmāhātmya accordavano loro piena legittimità, identificandole con dèi vedici e post-vedici e successivamente definendole non come semplici consorti di divinità maschili ma come poteri individualizzati dell’unica Grande Dea.
A questo proposito, il mito di Śumbha e Niśumbha ha una particolare immediatezza allegorica, perché la sfera d’azione è decisamente terrestre invece che cosmica o celeste. Gli dei, angosciati dal fatto che gli asura abbiano nuovamente capovolto l’ordine del mondo, invocano la Devī attraverso un magnifico inno, l’Aparājitāstuti (“Lode alla dea invincibile”, DM 5, 9–82), che ne celebra l’immanenza nel mondo come coscienza che si manifesta in tutti gli esseri. Quindi, la Devī appare sulla riva del Gaṅgā. La sua manifestazione sfolgorante, emanante dal corpo di Parvatī, incarna la guṇa di sattva, l’energia della luce, della purezza, della pace e della bontà. Avendo già rivelato i suoi aspetti tamasici e rajasici, appare sattvica e incredibilmente bella, sebbene assumerà forme diverse nel corso della battaglia.
La caratterizzazione tradizionale di Śumbha e Niśumbha come demoni di montagna enfatizza ulteriormente l’ambientazione terrestre e, di tutti i cattivi dei Devlmāhātmya, sono assieme alle loro coorti decisamente quelli più umani. Individualmente, Śumbha rappresenta l’ego mentre suo fratello minore il suo senso di attaccamento. Sono entrambi fondamentali per l’intero catalogo di fallimenti e vizi umani. La rappresentazione di Śumbha in mezzo al brillante eccesso delle sue ricchezze e dei suoi poteri ottenuti illecitamente è un’immagine disgustosa della corruzione e del materialismo spinti oltre il proprio limite. Caṇḍa e Muṇḍa, in tono adulatorio, fanno appello all’immensa vanità del loro padrone e ne infiammano la lussuria con allettanti descrizioni della bellezza seducente della Devi.
Approcciando la giovane dea a nome di Śumbha, il subdolo Sugrīva parla con l’intento di dissimulare e il di lei rifiuto, giustificato da un voto che la obbliga a sposare solo chi riuscirà a vicerla in battaglia, stabilisce il modello di relazione, fatto di sfide reciproche, che guiderà l’evoluzione della narrazione da quel momento in poi. Quando Śumbha ordina a Dhūmralocana di portargli la Devī, pur se “urlante e scalciante”, il povero malcapitato diventa una vittima della proverbiale violenza che genera violenza. Śumbha, ora spinto da rabbia irrazionale, manda Chaṇḍa e Muṇḍa a rimediare al fallimento di Dhūmralocana, al che la sattvica Devī evoca la sua terribile manifestazione, Kālī, che uccide rapidamente i due servi e il tutto loro esercito. Alla decisione di Śumbha di muovere l’attacco finale, la Devī moltiplica le sue forze evocando le sette feroci śaktis dagli dei e la sua stessa śakti, la terrificante Śivadūti. In risposta ricompare Raktabīja (“colui il cui seme è sangue”), con la sua straordinaria capacità replicativa. Il suo sangue rosso, simbolo di rajas, rappresenta l’incredibile potere del desiderio e dell’irrequietezza della mente. Proprio come ogni goccia che cade sulla terra produce un’altra asura, così un desiderio o un pensiero conducono ad un altro. L’indulgenza porta all’insaziabilità e la terribile metafora di Kālī che lecca il sangue gocciolante simboleggia il principio secondo cui i desideri umani e l’attività mentale incontrollata sono conquistati solo se stroncati sul nascere.
La morte di Raktabīja segna il punto di svolta. D’ora in poi il tema della crescente molteplicità si ribalta. Una ad una le manifestazioni esteriori dell’ego sono vinte e solo la sua essenza, rappresentata da Śumbha e Niśumbha, rimane in piedi a fronteggiare la Devī e le sue forze. La lunga battaglia con Niśumbha corre parallela alla vittoria della Devī su Mahiṣāsura. Entrambi i miti riguardano la metamorfosi del demone, il suo essere trafitto dalla di lei lancia e l’emersione di un essere interiore che viene infine decapitato. Quando Niśumbha, che simboleggia l’attaccamento, fa germogliare 10.000 braccia afferranti, la sua terribile trasmutazione non è un’emersione aggraziata come quella di Mahiṣa ma un atto di brutale disperazione. In entrambi i miti la lancia della Devī, che rappresenta l’intuizione, lascia l’asura esposto e vulnerabile. Il potente demone che emerge dalla ferita aperta sul petto di Nisumbha implora la Devì di fermarsi ma ad una vera sādhana le mezze misure non si confanno, e così lei lo uccide per mezzo della spada della conoscenza.
Ora rimane solo Śumbha, l’ego nudo. Quando rimprovera la Devī per aver fatto affidamento sulla forza degli altri, lei risponde che le śaktis sono solo proiezioni del proprio potere e prontamente le richiama a sé. Nel combattimento finale, la Devī e Śumbha ormai soli si alzano in cielo, simboleggiando l’allontanamento dal mondo. A conclusione della battaglia finale, quando Śumbha giace morto, il velo della nescienza individuale (avidyā) che oscura il Sé interiore viene sollevato. Nuvole metaforiche si disperdono per rivelare il sole splendente e la pace beata, la realizzazione della coscienza infinita.
[Tratto da “In Praise of the Goddess – The Devīmāhātmya and Its Meaning.” di Devadatta Kālī. Traduzione a cura di Alessandra Grana, Debora Menozzi, Edoardo Gobattoni.]